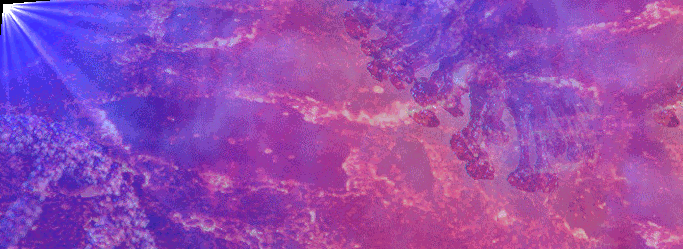Appunti liberi di Lezioni Magistrali - Parte Prima - Anthony Appiah: Che cos’è l’Occidente - Carpi, piazzale Re Astolfo, Sabato 15 Settembre 2007.
L’antropologia di Anthony Appiah può essere considerata una sfida rivolta alle forze che lacerano la società contemporanea, che sono alla base dei grandi conflitti culturali e religiosi. Queste lacerazioni sono il prodotto di filosofie che in un modo o nell’altro, a partire dalla fine dell’Illuminismo, hanno contribuito a ricostituire un pensiero dell’esclusione e della diversità. Contro queste tendenze l’obiettivo di fondo del pensatore di origine ghanese è un recupero ed un’attualizzazione del concetto di cosmopolitismo. Lo stoicismo antico, ma anche lo stoicismo romano, specie in Epitteto e Marco Aurelio, ha inaugurato il concetto di cosmopolitismo secondo il quale ognuno, anche colui che non appartiene alla poliV, non è più uno straniero oppure uno schiavo, bensì un cittadino del mondo come ogni altro, che vive secondo un principio razionale universale ed eterno (logoV). La proposta di riscatto dall’odierno conflitto di civiltà di Appiah parte da un principio molto affine al caposaldo della Stoà, per giungere a definire un ideale di cosmopolitismo contemporaneo.
Dalle origini del cosmopolitismo fino alla dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo, in seno al pensiero occidentale è esistito il desiderio di realizzare una societas hominum et communitas. Con il tramonto dell’Illuminismo le tracce di questo ideale si fanno sempre più rade, fino quasi a scomparire, mentre si affermano nuove correnti di pensiero che alimentano le fiamme irrazionali dei popoli, la mistificazione dell’alterità, il bisogno e il timore della sopraffazione, come ha fatto, per esempio, un certo Romanticismo. Accade il più delle volte che le concretazioni di tali correnti finiscano per trasformarsi in ciò che Appiah definisce “esagerazioni”. Un’esagerazione è una visione distorta della natura umana generatasi per via di errate interpretazioni della storia, dell’origine delle culture e della costituzione delle nazioni. Si tratta di espressioni del pensiero umano che non solo contribuiscono a generale l’idea che una cultura possa identificarsi con un determinato territorio, un determinato linguaggio, una determinata forma di governo, ma -e in totale controtendenza rispetto agli sviluppi più recenti della storia- non riconoscono un’esistenza di fatto all’ibridizzazione e al multiculturalismo.
L’ideale di una cultura isolata e pura può essere paragonata alla figura leggendaria della pepita d’oro. Appiah accusa la modernità di aver isolato le culture e affermato differenze illusorie, una patologia della storia umana che non si ravvisa soltanto in quello che egli definisce pensiero euro-vetero-centrista, ma anche nei suoi contraltari più giovani dell’americanismo e dell’afrocentrismo. Tutti i tentativi di affermare l’identità pura di una cultura, non soltanto vanno combattuti perché privi di qualunque oggettività, ma anche e soprattutto perché incapaci di rispondere agli interrogativi del fenomeno globale. Nel mondo contemporaneo, dove il transito e l’interlocuzione degli individui raggiungono una complessità mai avuta prima, non è più possibile parlare di cultura utilizzando categorie protoantropologiche, come ad esempio quelle che usò Tylor per rispondere alla domanda “che cos’è la cultura?”. Ancor meno adeguata è l’idea di cultura di Herder, ampiamente diffusasi fino alla metà del secolo scorso e confluita tra gli elementi costitutivi di modelli totalitari.
Talune esagerazioni, dice Appiah, dimostrano che non si è ancora completamente superato il modello della pace di Westfalia, che ha contribuito a fondare l’assetto dello Stato moderno. Mai come nel tempo in cui viviamo la nazione non può identificarsi con lo Stato. La vita delle comunità deve cominciare ad essere progettata nella sfera vitale degli individui e non più soltanto nei palazzi o dai filosofi. Il nazionalismo ha reso cieco l’Occidente moderno di fronte ad uno sviluppo della cultura in chiave ultranazionale. I residui di tale cecità sono ancora presenti in civiltà avanzate come le nostre: la Francia, gli Stati Uniti… La stessa Italia. In Italia per esempio il multilinguismo si riconosce soltanto in parte e in modo improprio. Si dice che l’Italia è un paese bilingue perché oltre all’italiano ci sono i dialetti e intanto si ignorano diverse minoranze linguistiche che esistono nel Bel Paese da tempo, come l’occitano, l’albanese, il somalo, l’arabo e altre ancora. Questi residui di cecità non fanno altro che accrescere la tendenza dei popoli a non riconoscere che di fatto sono già identità multiculturali. Essi accumulano sempre più saperi, ma nello stesso tempo dimenticano molto di ciò che appartiene al loro passato più proprio: la vicenda che ha fatto di ciò che affermano essere (ognuno un determinato popolo) quella comunità che oggi rappresentano.
Lo scrittore e storico francese Joseph-Ernest Renan, nella sua opera Qu'est-ce qu'une nation? rispose alla domanda del titolo dicendo che una nazione è una realtà complessa, fatta di storie, tradizioni, esercizi di potere, atti di resistenza e di mescolanze etniche. In una parola essa è una «realtà empirica». Ma l’errore di Renan fu di aver creduto che sono i valori del passato che le storie contengono a fare una nazione e non il fatto stesso che i suoi attori siano capaci di raccontarle, di rapresentarle attraverso l’arte, la scrittura, la musica, lo sport, oppure il viaggio. Sono questi i canali espressivi del cosmopolitismo culturale, gli stessi che rendono possibile un superamento del concetto moderno di nazione. Renan, quindi, è affetto da cattivo Romanticismo e per questo motivo egli interpreta il concetto di nazione esagerandolo, come hanno fatto l’Idealismo, l’Organicismo, e il Determinismo. Alle esagerazioni della modernità deve essere sostituito un cosmopolitismo culturale la cui universalità si esprime nelle forme condivise della creatività umana. Otto Wagner pensò al Gesamtkunstwerk come ad un’opera d’arte che fosse allo stesso tempo un’essenza unificatrice dell’arte in senso lato. Ma si trattava ugualmente dell’arte concepita come il prodotto di determinati popoli, ossia identità fondate sui valori tradizionali di cui si è detto, e per questo anche il Gesamtkunstwerk, seppure per un margine molto sottile, ricade nella cerchia delle esagerazioni dell’Occidente moderno.
Se possiamo dirci in cammino verso un cosmopolitismo contemporaneo, allora le categorie dell’Occidente moderno non possono più rappresentare la bussola con cui orientare i nostri parametri di giudizio (pensiamo a quando parliamo di Islam radicale, America settentrionale, popoli del terzo mondo che migrano da quadranti depressi ecc.). Essere cittadini del mondo non deve tuttavia significare omologazione della cultura ed ignoranza della diversità, poiché la diversità si identifica qui con l’altro, o meglio con l’umanamente altro, e l’umanamente altro è qualcosa che dobbiamo distinguere dall’estraneo. Il cosmopolitismo di Appiah è in fondo proprio questo: una convivenza dell’altro con l’altro, in un mondo senza estranei. I fondamenti del pensiero occidentale moderno sono quindi ciò che contraddice il cosmopolitismo contemporaneo, sono un controcosmopolitismo. In nessun luogo è una cultura che può dirsi pura e il controcosmopolitismo, dice Appiah, cerca una purezza immaginaria che non c’è.
...
Kwame Anthony Appiah (Londra, 1954). Filosofo e antropologo di origine ghanese. Lawrence S. Rockefeller Professor e membro del Center for Human Values presso la Princeton University, si è occupato a fondo della storia del colonialismo, del multiculturalismo e della cultura africana. Tra le sue opere: In My Father’s House. Africa in the Philosophy of Culture (1992); Color Conscious. The Political Morality of Race (1996); The Ethics of Identity (2004); Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers (2006).