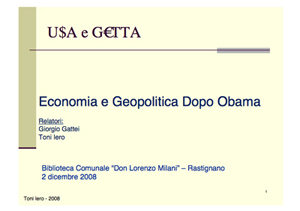02.12.08 "Usa e getta. Economia e geopolitica dopo Obama."
Commento alle slide relative all'incontro del 2 dicembre 2008. Come fonte per la
redazione di questo commento, sono stati utilizzati i libri di Toni Iero "La
Grande Crisi dei mutui" (autoproduzione, Bologna, gennaio 2009), e di Giorgio
Gattei "Pagherete caro, pagherete tutto, pagherete cash! La crisi dei mutui"
(edito da Ogni uomo è tutti gli uomini, Bologna, 2008).
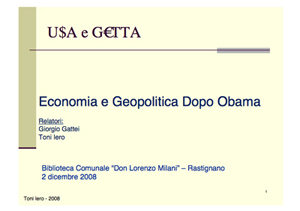
SLIDE (Versione Pdf)
Il commento alle slide in formato testo:
Slide 2 – La deflazione salariale anni ‘80
Le premesse dell’attuale crisi finanziaria vengono da lontano: dalla svolta neomonetarista degli anni ’80, i cui principali fautori sul piano politico furono, come noto, il presidente repubblicano Ronald Reagan negli USA e la premier conservatrice Margaret Thatcher nel Regno Unito. A partire da quegli anni, infatti, in tutti i Paesi occidentali si è assistito ad un profondo riassetto della distribuzione del reddito prodotto: la quota di PIL destinata al profitto ed alla remunerazione dei detentori di capitale finanziario è cresciuta in modo rilevante, a scapito dei salariati (nella slide la W sta per wage, cioè salario). Per rendersi conto di questo, basti riflettere sul seguente dato: i top manager delle grandi aziende e gli amministratori delegati delle multinazionali guadagnavano 30 anni fa un salario mediamente 35 volte superiore a quello di un impiegato medio; oggi, la proporzione è di 350 ad 1.
Slide 3 – Redditi da consumi (a credito)
Il principale motore della crescita economica è il sostegno ai consumi delle famiglie. Il lungo periodo di crescita economica mondiale tra la fine degli anni ’40 e gli inizi degli anni ’70, denominata addirittura con nomi mitologici quali golden age o golden thirties, si è basata sul cosiddetto “compromesso fordista-keynesiano”, caratterizzato dall’intervento dello Stato in favore dei sistemi di welfare (quindi spesa pubblica a sostegno della domanda, secondo la lezione keynesiana) e da salari elevati a sostegno del consumo di beni durevoli di massa (sulla base dell’intuizione fordista).
Ma la concentrazione del reddito provocata dalla deflazione salariale, a partire dagli anni ’80, rendeva più difficile il sostegno ai consumi delle famiglie. Per ovviare a questo problema, la soluzione adottata negli USA a partire dagli anni ’90, e soprattutto negli anni duemila, è consistita nel garantire la capacità di spesa delle famiglie dal loro indebitamento. L’abbassamento dei tassi d’interesse, l’avvento di carte di credito “revolving” (cioè carte con le quali i consumi vengono rimborsati a rate mensili), ed il rifinanziamento dei mutui contratti per l’acquisto di case sulla base dell’aumentato valore dell’immobile acquistato, sono stati i principali strumenti con cui sono state incentivate le famiglie americane a consumare a credito. E’ stato concesso il credito anche a cittadini cosiddetti “ninja”, ossia privi di reddito, di lavoro e di patrimonio (no job, no income, no asset).
Le merci consumate dalle famiglie americane vengono importate a basso prezzo dalla Cina, in cambio di moneta e titoli di stato. In parte questo avviene anche con l’Europa, con la differenza che le merci europee vengono pagate non soltanto in titoli di Stato, ma anche con titoli tossici emessi dalle banche americane a copertura del rischio di insolvenza delle famiglie cui hanno fatto credito. Per poterli collocare sul mercato, questi titoli tossici sono stati inseriti in obbligazioni – emblematicamente denominate “pacchetti salsiccia” – assieme ad altri titoli di migliore qualità; tali obbligazioni sono state quindi valutate col massimo voto dalle agenzie di rating (essendo esse stesse clienti delle società collocatrici di tali obbligazioni). I titoli tossici americani collocati nei mercati europei, pertanto, sono stati scambiati in cambio di moneta proveniente dall’Europa.
Slide 4 – La leva del debito negli USA
Tra il 2000 ed il 2006 la crescita del debito privato delle famiglie USA è stata quasi cinque volte superiore alla crescita del PIL!
Slide 5 – Inflazione finanziaria da debito
Si è visto che l’incremento del debito privato delle famiglie americane ha reso possibile un aumento dei loro consumi di beni mobili ed immobili. Ma l’aumento dei consumi e dell’acquisto di immobili comporta anche un aumento dei prezzi, il che equivale anche ad una crescita del valore del loro patrimonio immobiliare. Questo fornisce, a sua volta, una nuova garanzia per un nuovo debito. Questo aumento dei prezzi è chiamato “inflazione finanziaria da debito”. Il sostegno dei consumi tramite il facile accesso al credito è reso possibile dai bassi tassi d’interesse. Nella slide, C sta per consumi e P per patrimonio: la crescita di queste due grandezze è funzione (f) di Y, cioè del reddito, e di D, cioè del debito.
Slide 6 – L’inizio della Fine
Il sostegno ai consumi americani tramite indebitamento ha funzionato fintantoché i tassi d’interesse restavano bassi e le dimensioni di tale indebitamento erano ancora sostenibili. Ma il meccanismo ha cominciato a mostrare le sue prime crepe con il protrarsi delle guerre in Afghanistan ed in Iraq. Questa empasse ha impedito l’auspicato aumento dell’offerta di petrolio, mentre la domanda del greggio è in continuo aumento soprattutto a causa dello sviluppo economico dei Paesi asiatici. Pertanto, il costo del petrolio – che nel 2001 si aggirava sui 25 dollari al barile – inizia a crescere sensibilmente a partire dal 2004, stabilizzandosi sui 70 dollari nel corso del 2006. Inoltre, le spese militari in quegli stessi anni avevano provocato anche un aumento del deficit pubblico degli USA, arrivando nel 2006 al 5,7% del PIL, ed un progressivo deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro, anche a causa dei tassi d’interesse più elevati in Europa.
Per difendere il dollaro e per contenere un’eccessiva inflazione provocata dal prezzo del petrolio, oltre che dai consumi sostenuti dall’indebitamento facile, la FED si è quindi vista costretta ad alzare progressivamente i tassi d’interesse, dal 2% di inizio 2004 fino al 6,25% di fine 2006.
Slide 7 – Deflazione da debito
L’innalzamento dei tassi d’interesse ha rapidamente reso non più sostenibile l’indebitamento dei salariati americani, che si sono visti quindi costretti a rientrare dal debito. La necessità di sostenere il debito accumulato ha tolto non soltanto il sostegno ai consumi (gettando le basi per l’avvio di un processo recessivo), ma ha anche costretto molti a vendere il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare. Questo fenomeno, quindi, ha provocato sia la diminuzione dei prezzi degli immobili, sia la diminuzione dei prezzi di titoli (azioni ed obbligazioni). Si tratta, in pratica, del fenomeno inverso a quello che si è visto nella slide 5.
Slide 8 – Deflazione da debito (segue)
La deflazione da debito ha avuto delle conseguenze macroeconomiche molto gravi: sia perché, venendo meno il sostegno ai consumi, gli USA si sono avviati verso la stagnazione economica, se non verso una vera e propria recessione; sia perché la riduzione del valore patrimoniale degli immobili acquistati ha portato allo scoperto eccedenze di debito che le banche si sono affrettate a chiedere di coprire. I cittadini americani che non sono stati in grado di pagare il mutuo si sono visti pignorare le loro case, oppure le hanno dovute vendere, con conseguente loro deprezzamento. I titoli commerciali venduti dalle banche a copertura dei mutui prime e sub-prime su tutti i mercati finanziari mondiali (tramite il loro collocamento in pacchetti obbligazionari in cui venivano inseriti anche titoli buoni, come si è visto) sono così divenuti progressivamente sempre più inesigibili.
In altre parole, i titoli che fino al 2006 erano solo potenzialmente tossici (ma nessuno lo sapeva, visto che le agenzie di rating attribuivano loro la tripla A, ovvero il voto di massima affidabilità), dal 2007 in poi sono divenuti effettivamente tossici.
Slide 9 – Il paradosso di Irving Fisher
Pur partendo da una iniziale situazione di equilibrio finanziario, la deflazione da debito conduce paradossalmente ad una situazione di squilibrio: si tratta di un fenomeno che era già stato riscontrato in occasione della Grande Crisi negli anni ’30, e studiato da Irving Fisher. Lo si può comprendere con esempio: supponiamo che vi sia un patrimonio complessivo del valore di 100, a fronte del quale vi sia un indebitamento privato complessivo di 100; la situazione è dunque in equilibrio. Tale equilibrio permane fino a quando, per qualsiasi motivo (ad esempio un innalzamento dei tassi d’interesse) si scatena una deflazione da debito, come si è visto nelle due slide precedenti. A questo punto, infatti, gli indebitati devono vendere parte del loro patrimonio – supponiamo il 20% - per rientrare dal loro debito: il debito complessivo scende quindi a 80 (100-20). Ma la vendita del patrimonio complessivo provoca una sua svalutazione di pari entità, cosicché il patrimonio rimanente non vale più 80, bensì 64 (ovvero 80-20%): si noti che in questo caso si svaluta il patrimonio di tutti, anche di chi non ha contratto alcun debito!
La situazione è quindi in squilibrio, poiché a fronte di un debito rimanente di 80 si ha un patrimonio complessivo di 64, il che indurrà le banche a chiedere in misura ancor più massiccia ai loro debitori di rientrare. Questo, a sua volta, provocherà una nuova deflazione da debito in una spirale perversa che si autoalimenta, poiché anche chi non è indebitato, in una prospettiva di diminuzione ulteriore del prezzo del proprio patrimonio, sarà indotto a vendere. Famiglie, imprese e banche saranno indotte a “far cassa”, ovvero a tenersi ben strette il denaro liquido. Le banche saranno indotte a non fare più credito se non a tassi d’interesse ancora più elevati. Questo fenomeno è stato definito da Keynes “trappola della liquidità”.
Slide 10 – La propagazione della crisi
La crisi finanziaria provocata dai titoli tossici e dalla deflazione da debito si è rapidamente propagata anche all’economia reale, secondo un meccanismo piuttosto semplice: si è visto che la crisi finanziaria è iniziata per l’aumento delle difficoltà da parte delle famiglie americane a pagare i mutui ed i debiti contratti a sostegno dei loro consumi. L’aumento delle insolvenze ha provocato una massiccia offerta di immobili pignorati dalle banche che li hanno messi in vendita, determinando così un forte calo del valore degli stessi immobili. Le azioni delle banche e soprattutto delle grandi imprese finanziarie (che sono più esposte per via della cartolarizzazione del debito) hanno quindi ceduto vistosamente, trascinandosi il resto del listino azionario. Inoltre, al di là delle conseguenze finanziarie, che poi si vedranno, in tutti i Paesi occidentali la crisi di liquidità rende più dure le condizioni alle quali il sistema creditizio fa credito alle imprese.
Questa stretta creditizia (“credit crunch”), dunque, trasmette la crisi dall’economia finanziaria a quella reale, poiché le imprese trovano più difficoltà ad accedere al credito, e quelle già indebitate entrano più facilmente “in sofferenza”. Peraltro, la stagnazione dei consumi aggrava la congiuntura per le imprese stesse. In una spirale perversa, i fallimenti delle imprese provocano a loro volta delle insolvenze nei confronti delle banche ed un aumento della disoccupazione, mettendo così ancor più in difficoltà le famiglie.
Slide 11 – Quattro settimane vissute pericolosamente
Negli ultimi mesi del 2007, la detenzione di titoli tossici da parte di grandi gruppi finanziari europei ed americani, e le perdite subite dai loro titoli azionari, mettono seriamente a rischio la solvibilità di questi stessi gruppi finanziari. Citigroup, Merryl Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Lehman Brothers negli USA; UBS, Swiss Re, Northern Rock, West-LB, Crédit Suisse, Société Générale, Crédit Agricole e Deutsche Bank in Europa. Nel tentativo di contenere le conseguenze di questa crisi finanziaria, la Federal Reserve – l’autorità monetaria statunitense – adotta una rapida inversione della propria politica monetaria: dal 17 luglio 2007 al 23 marzo 2008 il tasso di sconto è sceso dal 6,25% al 2,5%; nei mesi successivi scenderà sotto l’1%, mentre si provvederà ad ingenti immissioni di liquidità nel sistema. Non c’è considerazione che tenga: quotazione del dollaro, conti con l’estero o altro, di fronte al grande spettro.
Lo spettro della “trappola della liquidità” si profila, in effetti, nel febbraio 2008, quando i correntisti della banca inglese Northern Rock si precipitano a far la coda agli sportelli per ritirare i propri risparmi. Per impedirne il fallimento, nella patria del neoliberismo e delle privatizzazioni il governo britannico si dovette precipitare a nazionalizzare la banca. Oltre alle nazionalizzazioni ed agli aiuti degli Stati, per salvare i sistemi bancari intervengono anche i fondi sovrani stranieri, entità finanziarie non sempre gradite, essendo di proprietà straniera di Paesi emergenti che dispongono di ingenti riserve valutarie in valuta straniera: Paesi arabi, Russia, Cina, Corea, Singapore ed altri ancora. Il rischio è che i Paesi detentori di tali fondi possano avere un qualche potere di indirizzo nei gruppi finanziari che vanno a salvare; tuttavia, spesso questi Paesi sono stati disposti a prestare il denaro dei loro fondi senza contropartite, solo per salvaguardare la preziosa domanda americana di petrolio e di merci.
Nonostante i massicci interventi delle finanze pubbliche e dei fondi sovrani, il peggio della crisi finanziaria non era ancora passato. Prima dell’estate 2008, sono entrate in sofferenza due istituzioni finanziarie private, la Freddie Mac e la Fannie Mae, che hanno erogato mutui immobiliari alle famiglie americane per 5.200 miliardi di dollari. Per rifornirsi di liquidità, queste due istituzioni hanno emesso obbligazioni che si sono sparse in altre banche, in fondi comuni e perfino nelle casse delle banche centrali. Il loro fallimento, dunque, avrebbe avuto ripercussioni su tutto il sistema finanziario, cosicché il governo statunitense si è precipitato a salvarle nazionalizzandole, ed assumendosi quindi i relativi debiti stimati in non meno di 200 miliardi di dollari. Per i risparmiatori americani (e di tutto il mondo) non c’è neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo, che all’inizio del mese di settembre un altro colosso finanziario si ritrova sull’orlo del fallimento: Lehman Brothers. Inizialmente pare debba essere salvato da un fondo sovrano sud coreano, che però si tira indietro, ritenendo l’affare troppo rischioso; si presenta allora la banca inglese Barclays, che tuttavia chiede una garanzia al governo USA pari al 10% degli attivi. Per il segretario di Stato al Tesoro Henry Paulson, ritenuto uno dei più autentici fondamentalisti del libero mercato, e per il governatore della Federal Reserve Bernanke è troppo: non si può incentivare il “moral hazard”, ovvero il rischio finanziario coperto dai soldi dei contribuenti. Dopo la nazionalizzazione di Freddie Mac e Fannie Mae, per gli eredi del neoliberismo era giunto il tempo che “la mano invisibile del mercato” facesse il suo corso. All’ultimo momento, si cerca un salvataggio da parte di Bank of America, che tuttavia è già impegnata a salvare Merril Lynch. Lunedì 15 settembre Lehman Brothers entra nella procedura fallimentare: in un sol colpo, oltre 600 miliardi di dollari in titoli si trasformano in carta straccia!
Passa un sol giorno, ed un altro colosso è sull’orlo del fallimento: si tratta della maggiore compagnia assicurativa al mondo, la AIG (American International Group), specializzata sui titoli derivati, tra cui quelli connessi alle cartolarizzazioni dei mutui, e che opera anche nei credit swap default (CDS), contratti assicurativi che proteggono contro l’insolvenza degli operatori economici. AIG è un colosso che opera il 130 nazioni, ed il governo americano non può più correre il rischio di altro fallimento: con 80 miliardi di dollari, dunque, il governo USA è divenuto l’azionista di maggioranza della AIG.
Slide 12 – Le Borse
Le quattro settimane successive al fallimento di Lehman Brothers furono davvero vissute pericolosamente dalle economie mondiali. Nonostante il successivo salvataggio di AIG da parte del governo USA, infatti, la sola possibilità che potessero esserci altri fallimenti di colossi finanziari provocò la perdita degli indici azionari nelle borse mondiali di oltre il 20%! La quotazione delle azioni di un fondo comune monetario indipendente che era in possesso di titoli Lehman, e che non aveva risorse consistenti cui attingere, è scesa sotto il valore di un dollaro nel giro tre soli giorni. Il panico ha contagiato tutto il mercato azionario, e in breve la Federal Reserve ha dovuto estendere la garanzia a tutti i fondi monetari. (cfr. George Soros, “La tempesta perfetta e le colpe americane”, La Repubblica, 3 febbraio ’09).
Slide 13 – I tassi interbancari
Nelle stesse quattro settimane, in Europa il tasso interbancario Euribor a 3 mesi, che riflette le condizioni sul mercato di domanda e offerta di moneta, è salito di quasi 50 punti base, dal 4,95% al 5,4%!
Slide 14 – La Rivoluzione d’Ottobre: le banche non possono fallire
Le quattro settimane vissute pericolosamente, quelle successive al fallimento di Lehman Brothers, sanciscono di fatto la fine del laissez-faire. E’ stato tale lo spavento dei mercati finanziari in queste quattro settimane che il governo americano è stato costretto ad annunciare la necessità della seguente terapia d’intervento definitiva: il governo si impegna ad acquistare da banche ed assicurazioni tutti i titoli invendibili sul mercato, soprattutto quelli legati ai mutui sub-prime. Secondo le dichiarazioni di Paulson, questo implicherà l’esborso da parte dell’esecutivo USA di oltre 800 miliardi di dollari (corrispondenti ai 650 miliari di euro indicati nella slide). E’ come se gli USA divenissero una sorta di aspirapolvere della spazzatura finanziaria emessa. Il Premio Nobel Paul Krugman ha definito questa misura “cash for trash”, ovvero denaro in cambio di spazzatura. Successivamente, il tesoro USA è dovuto intervenire per salvare la Bank of America (che a sua volta si era dissanguata per salvare Merrill Lynch), Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street e Wells Fargo. La Federal Reserve ha addirittura accettato di scontare gli effetti commerciali emessi dal sistema delle imprese per le loro esigenze di cassa bypassando così l’intero sistema bancario americano.
Ma non sono soltanto gli USA a dover intervenire in misura così massiccia per impedire il fallimento delle banche: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo sono intervenuti per salvare la banca Fortis; dopo Northern Rock, la Gran Bretagna deve nazionalizzare la Bradford & Bingley, la Bank of Scotland, la Hbos e Lloyds TBS; persino l’austera Germania è dovuta intervenire per salvare la Hypo Real Estate. Nel complesso, gli USA e gli Stati dell’Unione Europea hanno dovuto sborsare per salvare il sistema bancario oltre 3000 miliardi di euro, così come dettagliatamente riportati in questa slide.
Slide 15 – E l’economia reale?
Le drastiche decisioni che i governi e le autorità monetarie statunitensi ed europee hanno dovuto adottare per salvare i colossi finanziari ed i sistemi bancari nazionali, hanno avuto l’effetto collaterale di mettere in difficoltà quegli Stati che non sono in grado di estendere queste garanzie ai propri istituti di credito. Il caso più clamoroso è quello dell’Islanda, dove all’inizio del mese di ottobre dello scorso anno le tre uniche banche nazionali si sono trovate allo scoperto per 126 miliardi di dollari, una cifra pari a sette volte il PIL del Paese. Il governo islandese si è trovato costretto a nazionalizzale le tre banche, ma ha anche dovuto congelare i depositi bancari degli stranieri, ed allo stesso tempo ha dovuto chiedere aiuto. Sembrava che dovesse intervenire in aiuto il governo russo, ma poi, per evidenti ragioni geopolitiche, è intervenuto il Fondo Monetario Internazionale ed alcuni paesi (Giappone, Norvegia, etc.). Un caso simile si è verificato anche in Ungheria, dove la più grande banca nazionale è stata colpita dai ribassisti.
Ma il rischio di default da parte di intere nazioni non riguarda soltanto piccoli Paesi: sul mercato statunitense sono cresciute notevolmente le quotazioni dei titoli di Stato, ma soltanto quelli di breve periodo (a tre mesi), e non quelli a lunga. Questo avviene perché – si sussurra tra le sale operative – ormai “si inizia a guardare con occhi diversi anche il tesoro americano, e si preferisce investire sui suoi titoli di Stato con scadenze a breve. Il lungo termine lascia un senso di disagio” (citazione tratta da Moyra Longo, “T-bond da seconda guerra mondiale”, Il Sole24Ore, 18 settembre 2008). L’Institute for International Finance ha previsto, in effetti, che il governo americano debba emettere così tanti titoli al punto che, nel corso del 2009, il debito pubblico federale dovrebbe superare i 17mila miliardi di dollari, ovvero l’entità del PIL dell’intero Paese. Questo potrebbe provocare conseguenze sulla stabilità del dollaro, oltre che sull’affidabilità dello stesso debito pubblico USA.
Insomma, la gravità della crisi sta anche nel fatto che se gli Stati devono intervenire a salvare le banche, chi salverà gli Stati? Ovvero: chi potrà fornire risorse sufficienti agli Stati nazionali non soltanto per salvare le banche, ma anche per stimolare la domanda aggregata? Come recita questa slide, “Keynes, stavolta, potrebbe non essere più sufficiente!”
Slide 16 – Chi pagherà? – 1
Rispetto alla crisi degli anni ’30, quella attuale sembra avere caratteristiche ancor più negative, tranne che per il fatto che oggi è possibile trarre insegnamento dalle ricette di John Maynard Keynes. Ma dove si possono reperire le risorse per rilanciare la domanda? La prima possibile risposta è: da chi ce li ha, ovvero dal profitto e dalla rendita. Un aumento della pressione fiscale o una sua maggiore progressività è, dunque, una prima possibile soluzione (“lotta di tasse”).
Inoltre, anche una piccola spinta inflativa che dovesse determinarsi a seguito di una politica monetaria accomodante (e non può essere diversamente) e di uno stimolo alla domanda, avrebbe l’effetto positivo di uscire dalla deflazione. Ne trarranno vantaggio soprattutto gli indebitati, ma potrebbe penalizzare i salari.
Slide 17 – Chi pagherà? – 2
L’altra possibile risposta, e la più immediata, alla domanda “chi pagherà?” è: i profitti, grazie ad un aumento delle retribuzioni (“lotta di classe”). Ciò agevolerebbe il rimborso del debito delle famiglie nei confronti delle banche, anche se potrebbe accentuare la “sofferenza” delle imprese più indebitate o più in crisi.
Ma com’è possibile ottenere cospicui aumenti salariali se il mondo del lavoro è così debole, diviso, la disoccupazione è crescente, e gli stessi sindacati soffrono di una grave crisi di consenso? La risposta adottata nei primi anni della presidenza Roosevelt negli USA potrà sembrare incredibile: gli aumenti salariali sono stati riconosciuti per legge. Il National Labor Relations Act del 1935, passato alla storia come Wagner Act, riconobbe effettivamente per legge gli aumenti di stipendi e salari.
Slide 18 – La deflazione salariale – Anni ‘80
In pratica, si tratterebbe di restituire ai lavoratori almeno una parte della quota di ricchezza sottratta a salari e stipendi con la deflazione degli anni ’80.
Slide 19 – Acquistare il debito dell’Occidente
Si è visto che, almeno in una prima fase (fine 2007, inizio 2008), per assorbire parte dell’indebitamento privato entrato in sofferenza e dei titoli tossici, alcuni colossi finanziari e persino qualche piccolo Stato si sono rivolti ai fondi sovrani. Si è anche visto, però, che i 70 miliardi di dollari erogati da questi fondi non sono stati sufficienti a sostenere le istituzioni finanziarie, e – d’altro canto – questi fondi non sono sempre graditi, essendo di proprietà straniera, di Paesi spesso poco o punto democratici. Del resto, non si capisce perché gli Stati detentori di questi fondi dovrebbero continuare ad imbarcarsi in operazioni finanziarie rischiose senza una contropartita (oltre a quella di sostenere la domanda USA, come si è detto). A lungo andare, questi Stati potrebbero richiedere di avere un qualche potere decisionale nelle imprese che hanno contribuito a salvare.
Slide 20 – I fondi sovrani
Per i motivi esposti nella precedente slide, dopo una prima fase in cui i fondi sovrani hanno contribuito a salvare qualche colosso finanziario, gli Stati Occidentali hanno detto un “no” geopolitico agli interventi di salvataggio da parte dei fondi stranieri. Sia gli Stati Uniti che gli Stati europei, dunque, hanno deciso di intervenire soprattutto con l’emissione di titoli di debito pubblico. Per quanto riguarda gli USA, inoltre, parte del debito legato ai mutui sub-prime, come si è visto, è stato spalmato in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, attraverso le cartolarizzazioni e l’emissione di titoli tossici.
Slide 21 – Obama
L’era Bush, quella del sostegno del reddito mondiale attraverso i consumi a credito da parte delle famiglie americane, quella dei mutui facili e dei titoli tossici, quella delle guerre preventive e della spesa militare, è finalmente finita. Parte della soluzione per uscire dalla crisi passa, quindi, dal nuovo presidente democratico USA, ed in particolare da un inevitabile ritorno ad un profilo economico più protezionista: al crollo dei consumi privati, Obama rilancia i consumi pubblici, ovvero la spesa pubblica keynesiana per infrastrutture, ma anche per l’ambiente e la sanità, mentre dovrebbe ridursi quella militare, per lo meno per la graduale uscita dall’Iraq. Inoltre, la svolta ecologista dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza USA dal petrolio, in particolare da quello straniero.
Slide 22 – Globalizzazione
Questa crisi dovrebbe segnare, dunque, la fine della cosiddetta globalizzazione, così come è stata conosciuta finora, cioè con i consumi degli USA a far da traino per le esportazioni asiatiche ed europee. La crisi dei consumi negli Stati Uniti indurrà asiatici ed europei a puntare di più sui consumi interni.
Slide 23 – Nuova Globalizzazione
La “Nuova Globalizzazione” vedrà, quindi, un forte ridimensionamento del ruolo degli USA: anche se non potranno prescindere del tutto dalle importazioni, queste subiranno comunque un inevitabile rallentamento, come si è detto. Gli Stati asiatici, ed in particolare la Cina, potranno puntare sull’immenso mercato interno per continuare a sostenere la lunga fase di crescita economica. In Europa, invece, sarà necessario tornare a puntare sulla spesa pubblica keynesiana, non soltanto per le infrastrutture ma anche per la ricerca. Il centro degli scambi internazionali potrebbe spostarsi sul continente eurasiatico, e l’Europa potrebbe ritagliarsi un nuovo ruolo sulla scena mondiale.
Slide 24 – Nuovo ruolo dell’Europa?
L’isolazionismo americano, infatti, potrebbe favorire gli scambi tra Paesi Europei, Russia e “tigri” asiatiche, Cina su tutte. I primi fornirebbero tecnologia, ovvero scienza, ed eventualmente anche una solida moneta di riserva per gli scambi internazionali, specie qualora il dollaro dovesse perdere di stabilità o di affidabilità a seguito degli interventi del Tesoro americano per salvare i colossi finanziari e per sostenere i consumi pubblici. La Russia è la tradizionale fornitrice di materie prime sia per l’Europa (che paga in euro) che per la Cina e per i Paesi asiatici, mentre questi ultimi potrebbero continuare a fornire merci e prodotti finiti a buon mercato. Si realizzerebbe, così, ciò che gli strateghi geopolitici americani hanno temuto da sempre: l’unione dell’Hearthland (la Russia) con le Rimmland, o almeno con due di esse, cioè l’Europa e la Cina. Del resto, anche sulla terza Rimmland, quella medio-orientale, il controllo americano appare sempre più in crisi. La coalizione di queste potenze, dunque, potrebbe estromettere gli USA dal loro dominio geopolitico sul mondo: dominio che, peraltro, è già entrato in crisi con le empasse nelle guerre in Iraq ed in Afghanistan.
Slide 25 – Eurasia centro del mondo?
In questa prospettiva geopolitica, l’invocare da più parti la necessità di una nuova Bretton Wood che ridimensioni il peso degli Stati Uniti nell’organizzazione economica internazionale, potrebbe equivale, in realtà, ad una nuova Yalta (ancorché senza guerra mondiale). In questa occasione si potrebbe così ridefinire una nuova “cortina di ferro”, o almeno nuove zone d’influenza geopolitica: sotto il controllo USA resterebbe il Nord e (forse) il centro America, la Gran Bretagna, l’Australia, l’India, forse il Pakistan, il Sud-est asiatico, il Giappone, il Sudafrica, la Turchia, Israele, parte del mondo arabo (Arabia Saudita ed emirati satelliti, forse l’Egitto), e parte dell’Africa sub-sahariana. Sotto il controllo eurasiatico, invece, ci sarebbe tutta l’Europa (ma con qualche dubbio sui Paesi dell’Est recentemente entrati nell’UE, ma ancora legati alla NATO), la Russia, l’Asia centrale, compresa parte del mondo arabo (Iran, Libia,…), la Cina, la Corea, e parte dell’Africa sub-sahariana legata commercialmente alla Cina. Anche il Sud America sembrerebbe attualmente più legato al blocco “eurasiatico”, con i vari presidenti di estrazione socialista o popolare sempre più autonomi dall’influenza dell’amministrazione USA, e più vicini al governo socialista spagnolo.
E infine, due slide che rappresentano qualche aspetto emblematico di questa crisi – Slide 26
Il fondo sovrano della Libia di Gheddafi ha contribuito a salvare dal default alcuni Stati, quali l’Islanda, l’Ungheria, la Romania, ma anche gruppo bancario italiano Unicredit.
Slide 27 – Come si è visto, il fallimento del colosso finanziario Lehman Brothers, dopo oltre centocinquanta anni di storia, ha innescato la fase più turbolenta della crisi finanziaria.
 Il commento (Versione PDF) Il commento (Versione PDF)
|

 2007 La Fornace
2007 La Fornace