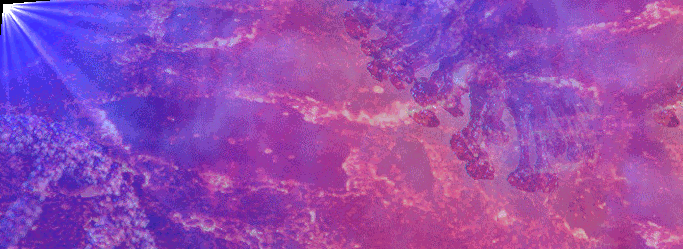(dal seminario del 13 marzo 2008 di Giorgio Gattei) a cura del Circolo Vittoria.
2000-2001: dalla crisi della new economy alla crisi dell’11 settembre
La crisi della new economy inizia nel 2001 con lo scoppio della “bolla di Internet”. Il Nasdaq (l'indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana) aveva cominciato a volare dal 1999 in un crescendo strepitoso che dura fino alla primavera del 2000. Prima di scoppiare i valori di borsa erano aumentati del 271%: in pratica, le quotazioni erano salite di quasi quattro volte. I sette-otto mesi della bolla sono stati la stagione d'oro, probabilmente irripetibile, della finanza mondiale. Qualcuno si era pure illuso che la crescita non avesse più fine ma poi, come l'impennata era stata velocissima, la caduta lo è quasi altrettanto. Fra marzo e aprile del 2000 l'incanto si rompe e il Nasdaq prende a precipitare. A fine anno 2000 è già a meno della metà e poi continua a scendere fino all'11 settembre 2001, il giorno dell'attacco alle Twin Towers di New York e al Pentagono a Washington. Allora si aggiunge anche lo sgomento per l’attentato terroristico, per la scoperta inedita che gli Stati Uniti sono vulnerabili anche al proprio interno. Prende così piede una “economia della paura” (di cui ha scritto Paul Krugman sul “New York Times” dell’ottobre 2001): la crisi di fiducia nelle aspettative di imprese e famiglie potrebbe essere tale da bloccare la crescita del PIL. Siamo forse alla vigilia del collasso dell’economia americana?
Superare la doppia crisi con la “bolla”
Naturalmente bisogna reagire. Secondo i rimedi pensati da Keynes per uscire dalla Grande Crisi del 1929-1933 si sa che il PIL può essere aumentare principalmente in tre modi:
? aumentando i consumi delle famiglie, il che si può raggiungere con un aumento dei salari;
? favorendo gli investimenti delle imprese mediante l’abbassamento dei tassi di interesse applicati al credito che le imprese chiedono per effettuarli;
? aumentando la spesa pubblica addirittura in deficit spending, ossia senza copertura finanziaria. Questa spesa pubblica può essere realizzata all’interno della nazione costruendo opere pubbliche, ma se all’interno si presentano ostilità insormontabili (la spesa pubblica è considerata dai benpensanti una spesa improduttiva), la si può rovesciare sull’estero mediante la guerra e la conseguente ricostruzione del paese avversario vinto.
E’ sulla base di queste ricette che negli Stati Uniti si procede. Da parte sua il governo decide subito di sostenere il PIL con lo strumento della guerra (è quello che in gergo è detto il “keynesismo militare”, dapprima in Afghanistan nel 2001 ma soprattutto in Iraq nel 2003, avendo per obiettivo il rilancio della produzione nazionale tramite le commesse belliche e la riduzione del prezzo del petrolio che si sarebbe guadagnato quando, dopo la sicura vittoria, sarebbero finalmente affluite sul mercato le ingenti riserve irakene (un affare stimabile attorno ai 3000 miliardi di dollari, a detta di James A. Paul, direttore del Global Policy Forum).
Anche la Federal Reserve si precipita a fare la sua parte abbassando il tasso ufficiale di sconto dal 6,5% del gennaio 2001 all’1% del giugno 2003. Qui però si presenta la necessità di introdurre una variante rispetto all’insegnamento keynesiano perché non si può più fare tanto affidamento sugli investimenti delle imprese finanziati a credito. Infatti nell’età della globalizzazione le imprese americane hanno delocalizzato all’estero molte produzioni, perché laggiù il costo della manodopera vi è più conveniente, e quindi non sono interessate ad investire più di tanto negli USA. Abbassare il tasso di sconto per loro non porterebbe dunque all’effetto sperato sull’economia nazionale.
E’ così che, con una innovazione pratica straordinaria, si decide di rivolgere quella riduzione del tasso di sconto al sostegno dei consumi delle famiglie mediante propaganda all’indebitamento immobiliare così che tutti posano diventare proprietari almeno della casa in cui abitano. E siccome il tasso d’interesse è annunciato a diminuire ancora (il governatore della FED affermerà pubblicamente nel novembre 2002 di essere pronto anche a portarlo addirittura a zero!), si incoraggia la stipula di mutui immobiliari ipotecari a tasso variabile rispetto a quelli a tasso fisso, così che le rate da pagare risultino nel tempo, col tasso d’interesse che diminuisce, sempre più ridotte. E siccome il valore di un immobile è pari alla somma delle rate da pagare divisa per il tasso di interesse, con quel tasso d’interesse a calare le famiglie si vedono aumentare il valore della casa che hanno messo a garanzia del debito contratto per acquistarla, e su quell’aumento di valore possono chiedere altro credito alle banche, da destinare questa volta direttamente ai loro consumi.
Per sostenere al massimo la crescita del PIL i mutui vengono concessi a chiunque, ossia non soltanto a clienti con un minimo di patrimonio oppure con garanzia immobiliare, ma proprio a tutti, perfino ai clienti NINJA (no income, no job and assets) che sono quelli che non hanno né stipendio né occupazione né patrimonio, ma a cui pure si aprono le porte del credito sebbene questi prestiti siano evidentemente al di sotto di qualsiasi livello di sicurezza finanziaria (ovviamente per il servizio di favore costoro pagheranno un tasso d’interesse più elevato del tasso di sconto, ma che sarà comunque anch’esso a calare).
Poi vengono diffuse le carte di credito “revolving” che consentono ai sottoscrittori di rateizzare il debito contratto con le banche pagando al mese soltanto una rata e posticipando al futuro il pagamento del rimanente, ovviamente ad un tasso d’interesse più elevato che però, per la politica monetaria accomodante della FED, peserà sempre di meno sulel tasche dei debitori.
L’esportazione della “bolla”
Ma non rischiano troppo per le banche a concedere così tanto credito senza adeguata copertura? Niente affatto se tutti questi mutui, anche quelli meno sicuri che sono detti subprime, possono essere “cartolarizzati”, ossia trasformati in titoli di banca commerciabili sul mercato e vendibili ad altri. Ma chi si azzarderebbe a comprarli? Così come si presentano, nessuno. Ma essi possono venire nascosti, insieme ad altri titoli garantiti con tasso d’interesse più basso perché a minor rischio, dentro obbligazioni collaterali di debito (i c.d. CDO, detti anche “pacchetti-salsiccia”) che, proprio per la presenza dei titoli sub-prime a tassi d’interessi più alti, danno nel complesso un rendimento più che appetibile per i risparmiatori.
Per nasconderli poi definitivamente intervengono le agenzie di rating che istituzionalmente hanno il compito di valutare i titoli in giro sui mercati, compresi quindi i CDO, misurandone la solvibilità mediante assegnazione di indici di qualità (AAA per i pacchetti più sicuri). E’ una funzione di controllo che dovrebbe servire a tutelare i risparmiatori sprovveduti (le valutazioni vengono fatte da esperti finanziari), ma siccome per questo servizio le agenzie di rating vengono pagate proprio dalle banche che hanno emesso quei titoli, esse sono naturalmente indotte a favorire i propri “datori di lavoro” sopravvalutando (assegnando quindi la qualità AAA, quando per esempio ai titoli del debito pubblico italiano era data la qualifica di AA- e si minacciava di diminuirla perché non proprio “affidabili”) anche a quei CDO con dentro i mutui subprime.
I quali, finalmente, ben nascosti nei “pacchetti-salsiccia” e sopravvalutati dagli indici di rating, hanno potuto circolar sfacciatamente per il mondo abbagliando i risparmiatori. Tutto congiurava per renderli apprezzabili quanti altri mai perché capaci di assicurare rendimenti più alti d’ogni altro titolo dipendendo da debitori ad alto rischio, ma presentandosi anche come più che sicuri perché favoriti della famigerata “tripla A”. Così facendo il rischio di perdita, che un tempo sarebbe pesato interamente sulla banca emittente il mutuo, è stato spalmato su di una platea così vasta di risparmiatori che anche nel caso del fallimento di un singolo CDO il danno per il mercato sarebbe risultato impercettibile.
Su questi “miracolosi” titoli di credito sono poi cresciuti altri contratti derivati e strumenti d’investimento strutturati (come i Siv e i Conduits), frutto della fantasia degli investitori professionali, allo scopo che tutti, ma proprio tutti, ci guadagnassero dall’indebitamento crescente delle famiglie americane.
Lo scoppio della “bolla”
Gli anni dal 2002 al 2006 sono stati una vera pacchia per i consumatori USA (che nel 2004, per riconoscenza, hanno rieletto Bush “il piccolo” senza necessità di brogli come era accaduto nel 2000). Ma va detto che lo sforzo di sostegno alla produzione del reddito mediante lo stimolo dei loro consumi è stato imponente se, a conti fatti, tra 2000 e 2006 si sono fatte indebitare le famiglie per 18.200 miliardi di dollari allo scopo di produrre appena 3.800 miliardi di dollari di PIL (risultato: il tasso d’indebitamento delle famiglie americane rispetto al reddito disponibile si aggira attorno al 130%; per paragone, in Italia siamo al 46%).
Era tuttavia una pacchia drogata dal credito facile che aveva un limite: esso poteva durare solo se i tassi d’interesse avessero continuato a diminuire. Ma questo avrebbe richiesto che la guerra irakena si chiudesse in fretta, consentendo gli Stati Uniti di chiudere la “bolla creditizia” con i nuovo affari e con il basso prezzo del petrolio. Ciò però non è stato perché, a dispetto dell’annuncio trionfale di “missione compiuta” nel maggio del 2003, la resistenza islamica ha trasformato l’Irak in un “pantano” che ingoia militari americani (pochi, almeno rispetto alle cifre della guerra del Vietnam) e assorbe risorse finanziarie che si ritorcono contro quel “credito facile” adottato per risolvere la crisi del 2000-2001.
? Intanto la guerra viene a costare sempre di più. Per l’economista premio Nobel Joseph Stiglitz è ormai una guerra da 3000 miliardi di dollari, quando invece si era affermato che non avrebbe superato i 50 miliardi. Ma come ha trovato tanti soldi il governo americano? Dapprima ha dato fondo all’avanzo di bilancio lasciato dalla precedente amministrazione Clinton, poi ha stampato dollari a piene mani così che il disavanzo federale ha finito per superare il 5% (a confronto, secondo gli accordi di Maastricht il limite del deficit statale è del 3%, oltre il quale scattano delle penali. Ma gli Stati Uniti non aderiscono all’Unione Europea).
? Contemporaneamentella spesa militare si è rivelata sul campo improduttiva per l’impossibilità di far fruttare gli investimenti previsti nella ricostruzione e di sfruttare il petrolio irakeno, su cui pure gli americani hanno messo le mani, a causa dello stato di “guerriglia permanente”. Così l’offerta petrolifera non è riuscita a seguire una domanda internazionale in crescita, con la conseguenza che il prezzo del petrolio è schizzato dai 20 dollari al barile del 2000 a oltre i 100 $/barile.
? Ma disavanzo federale in crescita + prezzo del petrolio a salire = inflazione interna? Non è detto, perché le famiglie americane, solleticate dal credito facile a disposizione, si sono messe a comprare le merci straniere importate dalla grande distribuzione commerciale perché più a buon mercato rispetto alle merci nazionali (le “merci cinesi”). Così facendo, nonostante l’aumento della domanda si sono potuti tenere sotto controllo i prezzi, ma la bilancia commerciale, ossia la differenza delle esportazione dalle importazioni, è finita in un crescente disavanzo.
Incombendo con l’andar del tempo i due “deficit gemelli” federale e commerciale (che hanno reso gli USA il paese più indebitato all’interno e verso l’estero del mondo), è stato necessario prendere dei provvedimenti correttivi. Per raddrizzare la bilancia commerciale si è svalutato il dollaro così da rendere le esportazioni americane più favorite (dal cambio 1:1 tra dollaro ed euro a fine 2002, adesso per un euro occorre più di un dollaro e mezzo); per raffreddare la frenesia creditizia si è rialzato il tasso d’interesse dall’1% dell’estate 2003 al 5,25% di metà 2007.
Soprattutto quest’ultima misura ha segnato per i consumatori indebitati la fine del “sogno americano”: sui debiti contratti a tasso variabile sono cresciute le rate da pagare mentre, riducendosi il valore patrimoniale degli immobili, veniva portato allo scoperto il credito eccedente e le banche, preoccupate, chiedevano di rientrare; il sistema delle carte di credito si è appesantito per la maggiore incidenza degli interessi sulla parte di debito rinviata al futuro; chi non è più in grado di pagare il mutuo immobiliare si vede pignorare la casa posta in garanzia oppure è costretto a venderla. E per i clienti ninja? Questi non pagano e basta. Sarà peggio per i loro creditori che però, grazie alla circolazione dei CDO “a tripla A”, sono ormai sparsi in tutto il mondo.
Così la crisi è diventata un collasso sistemico (che era invece quanto s’intendeva evitare con la spalmatura dei titoli su tanti creditori) rispetto al quale nessuno può sentirsi del tutto al sicuro. «Tutti i titoli in cui si suppone che la presenza di mutui sub-prime perdono di valore. Le agenzie di rating, i Soloni del pensiero unico economico, con l’improntitudine di chi si è fatto cogliere in fallo, effettuano un downrating di migliaia di titoli [ne abbassano gli indici di qualità]. Le banche che li possiedono non reggono il colpo. Ma non è che l’inizio. Ad agosto l’interbancario inizia a bloccarsi. Che vuol dire? Semplicemente che le banche non si fidano della altre banche e chiudono i normali canali di finanziamento all’interno del sistema creditizio. Crisi di fiducia che si trasforma immediatamente in crisi di liquidità. Intervengono le banche centrali europea, americana, giapponese e australiana per fornire liquidità al sistema. E’ un fiume di denaro che si riversa sulle banche. Centinaia di miliardi di dollari ed euro. Non basta. La crisi si ripete a ottobre, a dicembre, adesso. Le banche centrali, la FED in testa, incominciano ad accettare titoli “illiquidi” in garanzia. Lo fa anche la BCE, ma non vuole che lo si dica. Sarebbe a dire che le banche prendono denaro a prestito dando in garanzia alle banche centrali carta straccia» (Sbancor, Vampirismo geoeconomico, in rete).
L’ammontare della “bolla”
Potremmo così essere alle soglie di un collasso finanziario di dimensioni colossali. Ovviamente l’ammontare dei crediti insolvibili da mettere in perdita ai loro possessori non è misurabile con certezza, anche perché la compravendita di CDO ed altri titoli connessi è avvenuta in gran parte tra privati e fuori mercato. Le organizzazioni finanziarie internazionali hanno comunque provato a farne una stima che però coll’andar del tempo è diventata sempre più grande. Nell’agosto 2007 per il governatore della FED c’erano appena 100 miliardi di dollari di perdite in giro, però a novembre l’OCSE ne ha portato l’ammontare a 200-300 miliardi che la Banca d’Italia, a gennaio 2008, ha innalzato a 600 miliardi. Una valutazione complessiva di tutto quanto è a rischio d’insolvenza – non solo i mutui sub-prime ma pure i mutui prime a tasso variabile, non solo le carte di credito delle famiglie ma anche le banche e le imprese che hanno acquistato CDO ad alto rischio, non solo i derivati di subprime ma pure le monolines sull’orlo del fallimento (come Ambac e Mbia) e le agenzie di rating che perdono valore in borsa – porta però ad una cifra superiore ai 1000 miliardi di dollari, giusta la stima del Fondo Monetario Internazionale ad aprile 2008 ed il titolo del primo libro americano sulla crisi (The trillion dollar meltdown di Charles Morris). E siccome a tutt’oggi sono state effettuate svalutazioni presso i principali istituti finanziari (Merrill Lynch, Citigroup, UBS, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Nomura, Lehman Brothers, JPMorgan Chase, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Abn Ambro, Société Générale, Paribas, ecc.) per un ammontare di soli 200 miliardi, resterebbero ancora “in pancia” 800 miliardi di dollari di perdite da rivelarsi. A meno che non abbia ragione Nouriel Roubini, il più catastrofista tra gli economisti, che ha valutato la cifra impressionante di 3000 miliardi di dollari di perdite, esattamente quanto stimato da Stiglitz come il costo delle guerre americane in corso e come il valore previsto da John Paul dell’“affare irakeno”, se fosse andato a buon fine.
Come rimediare alla “bolla”
Per iniziare a smaltire il buco finanziario, sia le imprese multinazionali che gli istituti finanziari possessori di titoli-spazzatura hanno cominciato a mettere le perdite a bilancio, e questo non solo negli USA ma pure in Europa (una delle banche più colpite dalla crisi dei mutui americani è il colosso bancario elvetico UBS, che ha chiuso l’anno 2007 in rosso per la prima volta dalla sua nascita e prevede una perdita netta di circa 4,4 miliardi di franchi svizzeri. Anche Deutsche Bank e Merrill Lynch hanno chiuso in rosso: la prima per 131 milioni di euro e la seconda per 1,96 miliardi di dollari. Da parte sua Goldman Sachs ha tagliato del 15% il personale).
A rimedio la FED si è precipitata a cambiare la politica monetaria dedicandosi ad una frenetica riduzione del tasso d’interesse che è arrivata (per ora) al 2%. Ma non è stata seguita (sempre per ora) dalla Banca Centrale Europea, che pure aveva rialzato il tasso d’interesse fino al 4% del 2007 e poi continua a lasciarlo lì. Di conseguenza l’euro si apprezza sempre più sul dollaro, invogliando i risparmiatori ad abbandonarlo a favore della moneta europea (ma dove porterà questa “guerra monetaria” non è ancora dato a sapere...).
A Londra il governo laburista, invertendo la tradizione delle privatizzazioni, ha deciso di nazionalizzare una grande banca sull’orlo del fallimento, la Northern Rock, trasferendone (ma solo temporaneamente, secondo l’intenzione) la proprietà al settore pubblico; la Germania ha soccorso con denaro statale la Ikb Deutsche Industriebank; negli Stati Uniti la Bearn Stearns è stata acquistata dalla JP Morgan, preventivamente finanziata dalla FED. Sono forse i sintomi di un ritorno al tanto deprecato “capitalismo di Stato” negli anni della globalizzazione trionfante? Si sa che i lavoratori possono essere licenziati e le imprese possono fallire, ma le banche no. E quindi, vai al loro salvataggio!
Citygroup, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank, Blackstone e Barclays hanno invece scelto di chiedere aiuto ai fondi sovrani. Che fossero di Abu Dhabi, Singapore o Pechino non fa fatto, visto che il denaro non ha odore. Ma cosa sono questi “fondi sovrani”?
Ci salveranno i “fondi sovrani”?
La crisi in corso è originale perché non investe tutto il mondo. L’occidente ne viene colpito pesantemente, soffrendo d’insufficienza di liquidità, ma altrove... Altrove perdura il bel tempo, se il FMI prevede per il 2008/2009 una crescita del PIL superiore al 6 % in Russia, all’8% in India e oltre il 9% in Cina. Chi sta guadagnando dalla crisi sono i paesi che esportano energia (petrolio e gas) con prezzi in crescita, oppure che hanno surplus commerciali nell’esportazione di merci e servizi grazie ai bassi costi della manodopera. In cambio questi paesi incassano valuta estera che viene conservata quale riserva a difesa del tasso di cambio. Tuttavia queste riserve possono raggiungere un ammontare eccessivo, ed ecco la nascita dei fondi sovrani (sovereign wealth funds) destinati ad investire in strumenti patrimoniali e finanziari (e quindi azioni e obbligazioni, ma pure immobili ed imprese) quell’eccesso di riserve posseduto.
I fondi sovrani sono così nati nei paesi forti esportatori di petrolio: Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Norvegia (ed è il fondo pensione pubblico!), ma anche Singapore dove, grazie al rilevante surplus fiscale, il governo ha costituito il fondo Temasek, uno dei primi nati (nel 1974) e anche uno dei più attivi. Molto vivaci sono anche i fondi sovrani di Abu Dhabi e quello di Dubai, che detiene una quota del 5% nella Ferrari. La Cina dispone di ingenti riserve di valuta estera, grazie al notevole surplus commerciale, che ha investito soprattutto in titoli di Stato americani. Con la svalutazione del dollaro i Treasury Bond non sono risultati più tanto convenienti e così nel 2007 è stato costituita la China Investment Corporation, un fondo sovrano con una dotazione di 200 miliardi di dollari attivo sul mercato azionario.
Sebbene la presenza dei fondi sovrani non sia una novità, è soltanto con lo scoppio della “bolla” dei mutui sub-prime che la loro presenza si è mostrata con tutta la sua importanza. Le svalutazioni subite dai principali istituti finanziari potevano infatti essere ripianate grazie alla liquidità posseduta da quei fondi. E così è stato: soltanto nello scorso anno i primi 10 fondi sovrani hanno investito 73 miliardi di dollari spalmati su 52 operazioni di salvataggio o acquisizione. Nessuno ha eccepito sul fatto che fossero investitori governativi stranieri - e così Abu Dhabi è entrato in Citigroup, Dubai in Deutsche Bank, Singapore in UBS, Merrill Lynch e Barclays, mentre la prima operazione di China Investment Corporation è stata l'acquisto di circa il 10% del gestore di private equity Blackstone, cui ha fatto seguito l'investimento di 5 miliardi di dollari (il 9,9%) in Morgan Stanley.
I fondi sovrani non sono però del tutto innocui, avendo alcune caratteristiche difficili da digerire dal “libero mercato”. Innanzi tutto sono statali (sono i governi che li possiedono, compresi stati come Cina e Russia); non rispondono ad azionisti privati né sono tenuti a dare comunicazione ai mercati (non sono perciò “trasparenti”); non avendo di mira un dividendo annuo, investono nel lungo termine piuttosto che nel “mordi e fuggi” a breve, adottando strategie patrimonialistiche piuttosto che speculative; siccome la massimizzazione del profitto non è l’unica motivazione delle loro scelte, possono avere obiettivi di partecipazione in settori strategici (come infrastrutture, finanza, high tech, risorse energetiche e materie prime); sono particolarmente appetibili perché offrono liquidità immediata, ma se finora sono rimasti investitori “passivi”, potrebbero nel futuro chiedere di contare nelle decisioni aziendali, a partire dal diritto di voto in assemblea.
Il dibattito a favore o contro l’ingresso di questi fondi nel sistema proprietario delle imprese occidentali è appena all’inizio: respingerli oppure accoglierli a braccia aperte? L’esito dipenderà dalla dimensione della crisi. Attualmente i fondi sovrani sono presenti sul mercato con un ammontare complessivo stimato attorno ai 2500 miliardi di dollari, ma per il 2015 si prevede che ne avranno 12.000 miliardi (che, tanto per dare un’idea, corrispondono grosso modo al PIL attuale degli Stati Uniti). Troppi soldi per lasciarli alla finestra, se mai la crisi dovesse approfondirsi. Ma allora ne potrebbe derivare una mutazione epocale del rapporto imperialistico perché Europa e Stati Uniti, dal tempo di Lenin esportatori di capitali in tutto il mondo, finirebbero per diventare importatori di capitali altrui. Con tutte le conseguenze del caso.
Quanto è coinvolta l’Italia?
L’Italia sembra coinvolta solo marginalmente dalla crisi dei mutui. Il buco finanziario presentato dalle banche nazionali è relativamente basso, la più colpita essendo Unicredit con una esposizione ai mutui ad alto rischio iscritti a bilancio che a fine ottobre 2007 è stimata attorno ai 354 milioni di euro.
Ma le perdite interessano anche fondi d’investimento e fondi pensione, oltre che diversi enti locali, dai comuni alle regioni, che sono caduti nella trappola dei “derivati”. Secondo una ricognizione del Ministero dell’Economia a fine 2007 sarebbero 531 gli enti locali coinvolti per un ammontare complessivo di 38 miliardi di euro. La metà del debito (18 miliardi) farebbe capo a 19 regioni su 20, ma sarebbero coinvolte anche le province (per 3,5 miliardi), i comuni capoluogo (per 13 miliardi) e non capoluogo (per 3,5 miliardi) e perfino tre comunità montane (per 11,4 milioni di euro). L’obiettivo era di ottenere finanziamenti “a pronti” con periodi d’ammortamento lunghi abbastanza per gonfiare i bilanci senza aumentare le tasse comunali e rimandare alle giunte successive il debito da restituire comprensivo degli interessi (comunque con tasso a calare, che era quanto si prevedeva). Tutto questo per aggirare, senza tante discussioni politiche in assemblea, il taglio dei finanziamenti statali imposto dal “patto di stabilità interno” (che fa il paio, all’interno, con il più noto “patto di stabilità” di Maastricht).
E’ difficile recuperare i dati relativi ai singoli enti che hanno sottoscritto contratti derivati. L’unico elenco distribuito al pubblico è quello di Unicredit da cui risulta che i comuni lombardi clienti sono 16, tra cui Milano, per un totale di 950 milioni di euro. Il comune di Milano è attualmente indagato dalla magistratura per i contratti derivati collegati al maxibond emesso dalla giunta Albertini nel 2005 per rifinanziare alcuni vecchi mutui. Come riporta “Il Sole-24 ore” del 27 novembre 2007, per effettuare questa operazione la Giunta aveva selezionato quattro arranger: Depfa, Deutsche Bank, JP Morgan e UBS, a cui è stato dato un compenso dello 0,01%, pari a 168mila euro. Un volta selezionate le banche, Palazzo Marino ha lanciato il prestito obbligazionario a tasso fisso per un importo di 1,85 miliardi di euro. Ha però poi deciso anche di costituire uno «swap5 di ammortamento» (per trasformare la scadenza, che era in un'unica soluzione, in un piano di ammortamento pluriennale) e «una operazione di strumenti derivati di gestione del tasso d'interesse» (per trasformare il tasso fisso in uno variabile, perché si supponeva che diminuisse; quando invece è aumentato, il Comune si è accorto che il costo dell’operazione finanziaria aveva «subito un aumento superiore alle aspettative»). Il Comune ha sostenuto che il maxibond avrebbe fatto risparmiare 54,7 milioni di euro rispetto ai mutui preesistenti, più altri 5 milioni circa grazie allo swap5 sui tassi di interesse. In realtà, tra la prima firma di giugno 2005 e la rinegoziazione del settembre 2005, il Comune ha dovuto subire 20 milioni di costi dalla risoluzione anticipata di alcuni derivati già in essere con Unicredito banca d’impresa, più 48,1 milioni di valore negativo riguardante la parte di swap che andava risolto e che è stato assorbito dai quattro arranger, subito chiuso e addossato come minusvalenza sul derivato successivo. Questi 68 milioni di euro complessivi non tengono però conto delle commissioni bancarie da 30 milioni di euro, anch’esse assorbite come minusvalenza nel derivato legato al maxibond. Le rinegoziazioni successive hanno peggiorato la situazione con condizioni sempre più svantaggiose per il comune. Comunque si attendono i risultati della commissione di esperti, istituita dal Comune, per valutare l’entità del danno subito dall’amministrazione (cfr. “Il Sole-24 ore” del 7 febbraio 2008).
Glossario:
NASDAQ, acronimo di National Association of Securities Dealers Automated Quotation (ovvero: "Quotazione automatizzata dell'Associazione nazionale degli operatori in titoli") è il primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico, cioè di un mercato costituito da una rete di computer. Il NASDAQ è stato istituito a Wall Street il 5 febbraio 1971. Fino a qualche anno fa il NASDAQ è stato caratterizzato da una forte volatilità, dovuta al boom della cosiddetta New Economy, infatti il Nasdaq è l'indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana. L'indice, dopo essere partito l'8 febbraio con un valore iniziale di 100 punti, ha raggiunto un massimo storico di 5132 punti il 10 marzo 2000, in pieno boom della New economy
Cartolarizzazione: è la cessione di attività o beni di una società definita tecnicamente originator, attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari. Per lo più i beni ceduti sono costituiti da crediti, tuttavia possono essere immobili, contratti derivati o altro.
Rating: è un metodo utilizzato per classificare sia i titoli obbligazionari che le imprese in base alla loro rischiosità. Viene espresso attraverso un voto in lettere in base al quale il mercato stabilisce un premio per il rischio da richiedere all'azienda per accettare quel determinato investimento. I rating sono periodicamente pubblicati da agenzie specializzate, tra le principali: Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings. Esempio di classi di rating: Standard & Poor's:
AAA- Elevata capacità di ripagare il debito
AA- Alta capacità di ripagare il debito
A-Solida capacità di ripagare il debito, che potrebbe essere influenzata da circostanze avverse
BBB- Adeguata capacità di rimborso, che però potrebbe peggiorare
BB, B- Debito prevalentemente speculativo
CCC, CC - Debito altamente speculativo
D - Società insolvente
Mutui prime: con un discreto livello di sicurezza finanziaria, ad esempio clienti in possesso di lavoro stabile o di un patrimonio.
Derivati: sono strumenti finanziari il cui prezzo è basato sul valore di mercato di altri beni come azioni, indici di Borsa, valute, tassi, ma anche merci; ad esempio i derivati dei subprime sono i titoli ottenuti dalla cartolarizzazione di crediti immobiliari di tipo subprime. I derivati sono nati per coprire le imprese da una serie di rischi legati alle loro attività (ad esempio il rischio di aumento del tasso di interesse, di oscillazione dei prezzi delle materie prime o di credito). Gli swap (scambio) sono derivati che prevedono una scommessa con la banca e possono servire per coprirsi dal caro-tassi. Un’azienda per esempio che ha acceso un finanziamento a tasso variabile (mettiamo al 5%) teme che i tassi salgano; la banca gli fa questa proposta: “il tuo 5% lo pago io, tu pagherai a me un tasso fisso del 4,5%”; in teoria il cliente ci guadagnerà se i tassi saranno superiori del 4,5% e ci perderà se si attesteranno sotto questa soglia. I problemi dei derivati sono la loro complessità e i costi impliciti dei quali il cliente non riesce ad avere evidenza se non quando la banca inizierà a chiedergli grossi rimborsi.
Monolines: agenzie che assicurano parte del credito emesso da banche o fondi.